Nel campo della storia e della filosofia dell'arte - e di quella asiatica e del subcontinente indiano in particolare - lo studioso singalese Ananda Kentish Coomaraswamy (1877-1947) è uno dei principali esponenti di quell'approccio che si definisce "tradizionalista". Distintiva di tale approccio, cui sono riconducibili personalità molto diverse tra loro - da René Guénon a Mircea Eliade a Élemire Zolla, per limitarsi a tre nomi celebri - e che ha tangenze significative anche in storici dell'arte di formazione rigorosamente eurocentrica come Hans Sedlmayr, è la rivalutazione dei contenuti spirituali che, ad ogni latitudine, innervano le culture tradizionali, e i cui fondamenti metafisici stanno alla radice delle grandi costruzioni filosofiche sviluppatesi in età antica e medievale. Nel corso della sua carriera, svoltasi prevalentemente in India, Gran Bretagna e Stati Uniti e culminata con l'incarico di Responsabile del Dipartimento di Arte Indiana, Persiana e Musulmana del Museum of Fine Arts di Boston, Coomaraswamy sviluppò il suo pensiero in una vasta costellazione di saggi, articoli, recensioni. Nella disamina di Coomaraswamy, tutti i nodi vengono al pettine, e molte sue conclusioni potrebbero apparire manichee, volutamente paradossali nel loro antimodernismo. In realtà, l'antimodernismo di Coomaraswamy è una posizione non solo filosofica ma anche - e forse di più - filologica. Radicalmente contrario ai miti del progresso e alla retorica della divulgazione e della semplificazione, egli sprona il lettore ad andare direttamente alle fonti del sapere antico, diffidando delle riscritture, delle alterazioni, delle falsificazioni imposte dalle contingenze presenti. Il saggio che qui presentiamo (titolo originale: Why Exhibit Works of Art?; traduzione nostra), nacque come conferenza per la American Association of Museums di Columbus (Ohio) e Newport (Rhode Island), e uscì sulla rivista Journal of Aesthetics and Art Criticism, autumn 1941, pp. 27-41. Per l'edizione italiana a stampa, vedi A.K. Coomaraswamy, Perché esporre le opere d'arte?, in La filosofia dell'arte cristiana e orientale, a cura di Grazia Marchianò, Abscondita, Milano 2005, pp. 13-27. Le immagini che corredano il testo sono il frutto di una scelta redazionale.
A cosa serve un Museo d’Arte? Come implica la parola “Curatore”, la funzione primaria ed essenziale di tale museo è custodire opere d’arte antiche o uniche nel loro genere che, prive ormai della loro collocazione originaria o della funzione a cui erano state destinate, rischiano di andare in rovina per abbandono o per altri motivi. Ma la cura delle opere d’arte non comporta la necessità di esporle.
A chi si domandasse perché queste opere debbano essere non solo difese, ma anche mostrate e rese accessibili e spiegate al pubblico, potremmo rispondere che ciò ha una finalità educativa. Ma prima di esaminare un tale scopo, prima di chiederci: “Educare a cosa e perché?”, sarà bene distinguere tra l’esposizione di opere di artisti viventi e quella di opere antiche o relativamente antiche, o di provenienza esotica. È del tutto superfluo che i musei espongano le opere di artisti viventi, che non corrono il rischio imminente di essere distrutte; nel caso le si esponga, non devono esservi dubbi su ciò che il museo sta facendo, ossia pubblicizzare l’artista per conto del mercante o del mediatore, il cui scopo è precisamente quello di procurare all’artista un mercato; l’unica differenza è che il museo, pur facendo lo stesso tipo di lavoro del mercante, non ne trae alcun guadagno. D’altro canto, che un artista aspiri a vedere le proprie opere “appese” o “esposte” nel museo, dipende soltanto dalla misura del suo bisogno o della sua vanità. Infatti le cose sono di norma prodotte in vista di determinati scopi e per luoghi appropriati, non soltanto “per mostra”; sicché tutto ciò che è prodotto per una clientela, nel nostro caso da un artista per un fruitore, dovrà obbedire a determinate esigenze e norme. Invece, come ha di recente affermato Steinfels, “le opere create esclusivamente per essere esposte in un museo appartengono a un genere d’arte che non tiene conto della sua relazione con l’ambiente finale a cui sono destinate. L’artista può dipingere le opere che vuole, nel modo che vuole, e se i conservatori e gli amministratori del museo lo ritengono, non faranno che allinearle alle pareti accanto alle altre curiosità”.
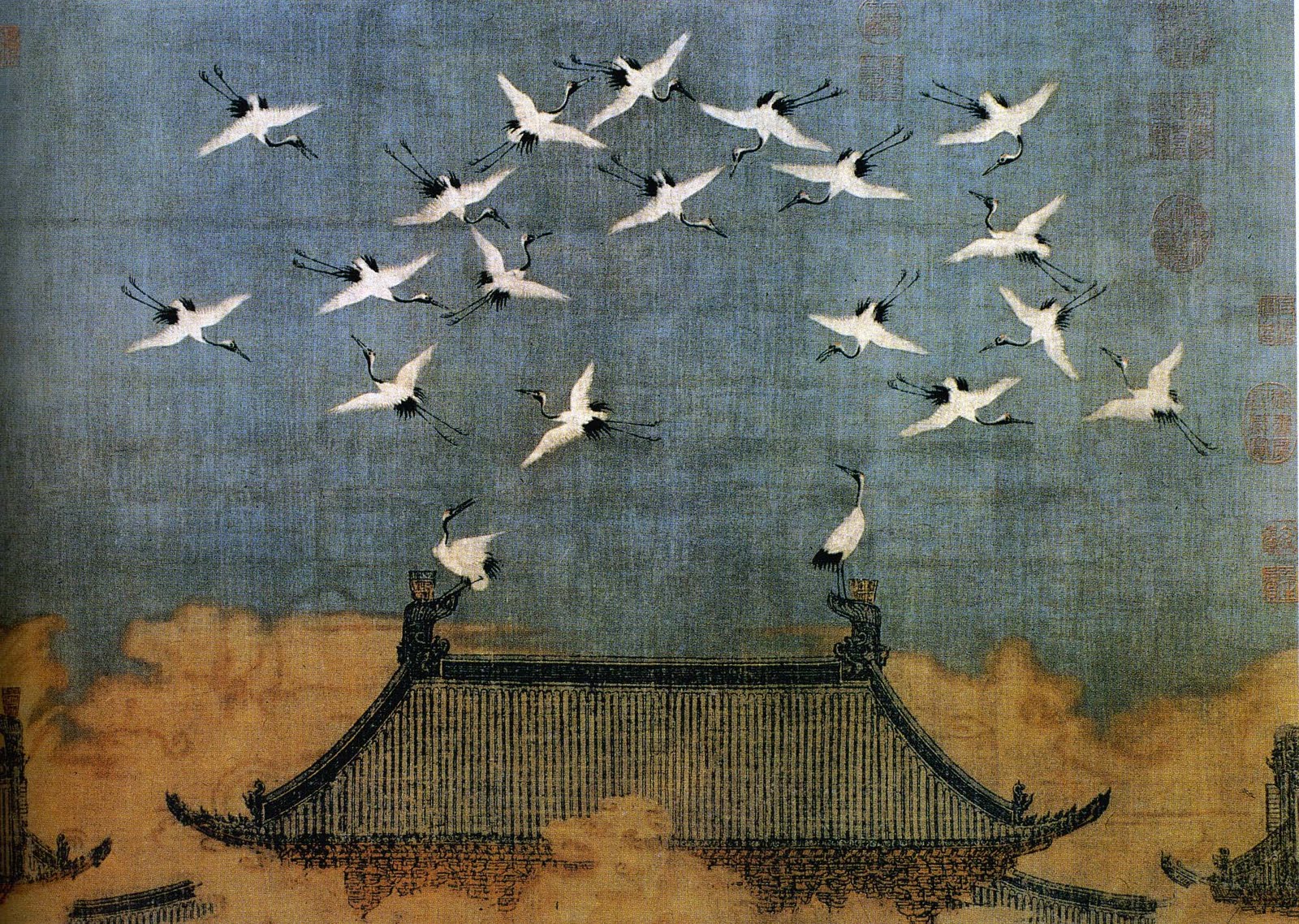
E veniamo al problema di fondo, “Perché le esponiamo?”, così come esso si applica alle opere d’arte più o meno antiche o esotiche che, vuoi perché rese fragili dal tempo, vuoi perché ormai incapaci di rispondere ai bisogni per noi più consueti, sono custodite nei nostri musei, delle cui collezioni costituiscono il nucleo essenziale. Se intendiamo mostrarle non come mere curiosità, ma per ragioni educative, è ovvio che ci proponiamo di fruirle in un modo che prescinde da una loro utilizzazione concreta. Sarà soltanto in modo immaginario e non reale che useremo il reliquiario medioevale, o ci stenderemo sul letto egizio o faremo offerte davanti a una sacra icona. Gli scopi educativi che può assolvere un’esposizione esigono di conseguenza non solo l’intervento di un curatore che la allestisca, ma anche di un esperto, che illustrerà sia i bisogni originari del committente sia i metodi praticati a suo tempo dall’artista; infatti, se le opere giunte fino a noi e custodite nel museo sono ciò che sono, dipende da chi furono e cosa vollero gli artisti che le crearono e i committenti che le ordinarono. Se l’esposizione vuole essere qualcosa di più di una rassegna di curiosità e di un’occasione di svago, non basterà accontentarsi della nostra reazione di spettatori; per conoscere le ragioni del loro essere come sono, occorre conoscere gli uomini che le produssero. Né sarà “educativo” interpretare il significato di tali oggetti in base alle nostre reazioni di piacere o dispiacere, o ritenere che quegli uomini pensassero l’arte a modo nostro, o fossero spinti da motivazioni solo estetiche o volessero “esprimere se stessi”. Dovremo invece esaminare la loro teoria dell’arte, anzitutto per comprendere il senso di ciò che essi hanno realizzato con l’arte, e poi per accertare se quella teoria, posto che risulti diversa dalla nostra, non sia stata per caso più valida.
Immaginiamo di passare in rassegna una collezione di opere greche, e di ricorrere a Platone come esperto. Egli ignora la distinzione moderna tra belle arti e arti applicate. Per lui, pittura e agricoltura, musica, falegnameria o ceramica sono allo stesso titolo espressioni della poesia o del fare. E come, in accordo con Platone, afferma Plotino, arti come la musica o la lavorazione del legno non si basano sulla conoscenza umana ma sulla sapienza ideale.
Ogniqualvolta Platone denigra le “vili arti meccaniche” o distingue il “lavoro” puro e semplice dalla “manifattura artistica”, si riferisce all’insieme dei prodotti concepiti per soddisfare i soli bisogni del corpo. L’arte che gli appare giusta e pertanto degna di rientrare nello stato ideale, non dovrà limitarsi a essere utile ma anche vera rispetto ad appropriati modelli, e dunque bella, e in tal caso essa soddisferà allo stesso tempo le esigenze, egli dice, “dell’anima e del corpo dei cittadini”. Il suo concetto di “musica” include tutto ciò che noi intendiamo per “cultura”, e “ginnastica” sta per tutto quanto attiene oggi all’addestramento e al benessere del corpo; egli insiste sul fatto che i fini dell’educazione intellettuale e fisica non vanno perseguiti separatamente; né l’artista esangue né il rozzo atleta sono esempi da seguire. Noi, d’altra parte, siamo abituati a considerare la musica e la cultura, in genere, come qualcosa di inutile seppure apprezzabile. Dimentichiamo che dal punto di vista tradizionale la musica non è fatta soltanto per essere ascoltata, ma deve sempre accompagnare un qualche tipo di azione. Le nostre idee sulla cultura sono improntate alla negatività. Credo che Dewey abbia ragione a definire snobistici i nostri valori culturali. La lezione del museo va applicata alla vita.

Poiché non intendiamo occuparci degli oggetti esposti, dovremo dare per scontata la loro idoneità all’uso, ossia la loro efficienza, e chiederci piuttosto in che senso essi incarnino anche una verità e un significato; se infatti sono inadatti, oggi, a soddisfare i nostri bisogni materiali, può darsi che siano in grado di appagare le esigenze dello spirito o, se preferiamo, della ragione. Quello che Platone intende per “vero” è ciò che è “iconograficamente corretto”. Sebbene tutte le arti, senza eccezione, siano rappresentazioni o immagini di un modello, ciò non significa che siano in grado di mostrarcene il volto autentico – cosa impossibile, visto che le forme dell’arte tradizionale sono imitazioni di modelli ideali e dunque invisibili – bensì che il loro potere analogico è tale da risvegliare alla mente il ricordo dei loro archetipi. Le opere d’arte sono sollecitatori della memoria, ovvero sostegni alla contemplazione. Ora, poiché la contemplazione e la comprensione di queste opere deve appagare le esigenze dello spirito, ossia, secondo Platone, accordare e intonare i nostri modi distorti di pensiero alle armonie del cosmo affinché, citando le sue stesse parole, “per l’assimilazione del conoscente con il conosciuto, cioè con la natura archetipica, noi si possa attingere a quel ‘meglio della vita’ concesso all’uomo dagli dei in questo e nell’altro mondo” o, in termini indiani, compiere la nostra reintegrazione armonica nel cosmo attraverso l’imitazione delle forme divine al fine di giungere, secondo l’Upanishad, a “diventare ciò che si pensa”, ne consegue che è non solo indispensabile che le forme dell’arte siano degli indicatori adeguati dei loro paradigmi, ma che la natura di questi sia tenuta nel massimo conto ai fini di attribuire all’arte un valore seriamente “culturale”. Il cosa è l’arte è assai più importante del come ; anzi, dovrebbe essere il cosa a determinare il come, così come la forma determina la figura concreta.
Platone non perde mai di vista la rappresentazione delle forme invisibili e intelligibili. L’imitazione fine a se stessa è disprezzabile; il vero tema dell’arte sono le imprese di dei ed eroi, non i sentimenti personali dell’artista e neppure le umane inclinazioni nella loro effimera soggettività. Un poeta capace di rappresentare le instabili propensioni della nostra natura, ma incapace di imitare i modelli eterni, non ha posto in una società ideale, per verosimili e attraenti che siano le sue immagini verbali. L’assiriologo Andrae concorda perfettamente con Platone quando, a proposito della ceramica, afferma che “è compito dell’arte cogliere la verità ancestrale, rendere udibile il non udibile, enunciare la parola primordiale, riprodurre le immagini dei primordi, altrimenti non è arte”. In altri termini, l’arte vera consiste in una rappresentazione simbolica e significativa di aspetti della realtà che non sono visibili altrimenti che dall’intelletto. Così intesa, l’arte è l’antitesi di ciò che normalmente intendiamo per educazione all’immagine, in quantoché mira a indicarci l’aspetto di cose che non vediamo, e tuttavia potrebbero essere. È istintivo nel bambino procedere dall’interno all’esterno: “Prima penso, e poi raffiguro il mio pensiero”. E quanto sono inutili i nostri sforzi per insegnargli a non pensare ma solo a osservare! Invece che allenarlo al metodo e all’oggetto dell’osservazione interiore, ci preoccupiamo di fargli “correggere” il disegno sulla scorta di quanto vede all’esterno. È chiaro che il museo, nella sua forma ottimale di realizzazione, non può che essere il nemico giurato dei metodi educativi oggi prevalenti nelle nostre Scuole d’Arte.

L’ammirazione di Platone per l’arte del tempo antico era solo rivolta al “miracolo greco” nell’arte; le sue lodi per l’arte canonica dell’antico Egitto dipendevano dal fatto che “quei modi (di rappresentazione), per natura corretti, sono stati stimati sacri da sempre”. È il medesimo punto di vista dei filosofi scolastici per i quali “l’arte ha fini precisi e mezzi accertati di esecuzione”. Nuove canzoni, certo, ma mai e poi mai tipi differenti di musica, giacché essi potrebbero distruggere la nostra intera civiltà. Sono gli impulsi irrazionali che inseguono il nuovo. La cultura moderna, sentimentale ed estetica – dove sentimentale, estetico e materialista sono virtualmente sinonimi – è incline a preferire l’espressione istintiva alla bellezza formale dell’arte razionale. Ma Platone non avrebbe notato alcuna differenza tra il matematico esaltato da una “splendida equazione” e l’artista rapito dall’intuizione della forma. Egli ci incita a resistere da uomini alle nostre reazioni istintive al piacevole e allo spiacevole, e ad ammirare nelle opere d’arte non le superfici estetiche ma la logica e il criterio interno della loro composizione. Perciò egli può asserire che “la bellezza della retta, del circolo e delle figure piane e solide da essi formate […] non è relativa, come nel caso degli oggetti ordinari, ma assoluta”. Se si sommano queste annotazioni all’insieme dei suoi giudizi sull’arte umanistica in voga in quel tempo, e sull’arte egizia, il tutto equivale a una approvazione dell’arte greca arcaica e di quella geometrica, le cui forme rispecchiano fedelmente il contenuto dei miti e dei racconti che così spesso egli cita e ammira. Per dirla in termini a noi più familiari, da questo punto di vista la pittura su sabbia degli indiani d’America è nel suo genere superiore a qualsiasi dipinto realizzato in Europa o nell’America bianca da molti secoli in qua. Come più di una volta mi ha fatto notare il direttore di uno dei cinque massimi musei dei nostri Stati dell’Est, “Dall’età della pietra a oggi, che declino!” Alludeva, ovviamente, a un declino in termini intellettuali, non di benessere. Tra i compiti di un museo ben organizzato dovrebbe esservi quello di far svanire ogni illusione di progresso.
Mi sia lecita a questo punto una digressione per rettificare un equivoco ampiamente diffuso. È impressione generale che l’arte astratta moderna, oltre che apparire simile a quella primitiva, sia stata perfino “ispirata” dal suo formalismo. È invece una somiglianza del tutto superficiale. L’astrazione moderna non è che una forma di manierismo. L’arte neolitica è astratta, o meglio algebrica, perché solo una forma algebrica può fungere da forma unica di una molteplicità di cose diverse. Le forme dell’arte greca arcaica sono tali perché solo in esse è possibile mantenere l’equilibrio di polarità tra il fisico e il metafisico. “L’aver dimenticato questo principio” ha affermato di recente Bernheimer “davanti al miraggio di modelli e disegni assoluti è forse la sciocchezza più grande commessa dall’astrattismo in arte”. L’astrattista odierno dimentica che il collega formalista del Neolitico non era un decoratore di ambienti ma un metafisico, il quale sapeva cogliere la vita nella sua interezza e doveva vivere del suo ingegno; un uomo che, al contrario di noi moderni, non viveva di solo pane, se è vero che le sculture primitive, come ci confermano gli antropologi, sapevano sopperire ai bisogni sia dell’anima sia del corpo. L’occasione di testimonianza offerta dal museo dovrebbe dunque stimolare a un ritorno a quei livelli selvaggi di cultura.

Tra le naturali conseguenze dell’esposizione al pubblico dovrebbe esservi quella di indurlo a chiedersi perché mai oggetti “da museo” si trovino raccolti in luoghi speciali e non siano fruibili nella vita quotidiana. Si tratta infatti quasi sempre di oggetti non considerati all’origine “tesori” da ammirare in vetrina, ma cose del tutto comuni che chiunque poteva utilizzare e acquistare sul mercato. Qual è la causa profonda dello scadimento qualitativo dell’ambiente in cui viviamo? Perché dipendiamo in maniera così notevole da ciò che si definisce “antiquariato”? L’unica risposta possibile non farà che mettere in luce la posizione antitetica del museo rispetto al mondo. Giacché, mentre gli oggetti del tempo antico erano stati concepiti e realizzati per una clientela, in vista dell’uso, i prodotti delle nostre fabbriche sono programmati unicamente in vista della vendita. Il termine stesso manufacturer (“fabbricante”), uno che fa cose a mano, oggi non significa altro che un venditore di merce fatta a macchina. Gli oggetti esposti nei musei furono prodotti con mezzi manuali da uomini responsabili, il cui mestiere, che serviva al loro sostentamento, era a un tempo una vocazione e una professione. Sono oggetti prodotti da uomini liberi. Possiamo dire altrettanto di quelli ammucchiati nei grandi magazzini? C’è da dubitarne seriamente.
Quando Platone afferma che “le arti provvedono ai corpi e alle anime dei cittadini”, e che devono essere realizzate solo opere sensate e libere, non certe vergogne inadatte a uomini liberi, ciò equivale a sostenere che l’artista, quale che sia il materiale su cui opera, deve essere un uomo libero, non nell’accezione comune sottesa all’espressione “artista emancipato”, libero da impegni o doveri, ma bensì emancipato dalla tirannia del venditore. Se è compito dell’artista rappresentare le realtà eterne, allora bisogna che egli sappia quali sono. In altre parole, un atto dell’immaginazione, in cui l’idea da rappresentare sia all’inizio racchiusa in una forma imitabile, deve precedere l’operazione con cui quella forma si imprimerà nella materia. Di questi due atti, il primo si definisce “libero”, il secondo “servile”. Ma è solo trascurando il primo che “servile” acquisterà una connotazione spregiativa. Non occorre rilevare che i nostri metodi di fabbricazione sono servili proprio in questo senso, né si può negare che il sistema industriale, per il quale il ricorso a tali metodi è indispensabile, è inadatto a uomini liberi. Un sistema di produzione quantitativa dominato da criteri venali presuppone l’esistenza di due tipi diversi di lavoratori: gli “artisti”, privilegiati e provvisti di “ispirazione”; e gli operai, asserviti e ritenuti sprovvisti di immaginazione, dal momento che si chiede loro di eseguire ciò che altri hanno immaginato. Come osserva Eric Gill, “da un lato c’è l’artista tutto proteso a esprimere se stesso; dall’altro, l’operaio, privo di qualsiasi identità personale cui dare espressione”. Si è spesso affermato che i prodotti dell’arte “bella” sono inutili; ma sarebbe derisorio definire libera una società in cui possono dirsi liberi solo i creatori di cose inutili, non quelli di cose utili, se non nel senso che siamo tutti liberi di lavorare o di morire di fame.

È dunque attraverso il concetto del lavoro secondo vocazione, distinto dall’ordinario procacciarsi il pane esercitando un lavoro qualsiasi, che emerge la differenza tra gli oggetti esposti nel museo e quelli dei grandi magazzini. In tali condizioni, che sono poi quelle di tutte le società non-industriali, dove ciascun uomo produce un solo genere di cose e fa il solo tipo di lavoro a cui la sua natura lo chiama e a cui è destinato, Platone ci avverte che “si può fare di più, e meglio che in qualsiasi altra maniera”. In tali condizioni il lavoro svolto dall’uomo è quello che più corrisponde alle sue inclinazioni, e il piacere che ne trae completa l’opera. È un piacere chiaramente percepibile negli oggetti esposti nel museo, ma che risulta del tutto assente in quelli usciti dalla catena di montaggio, simili più a cose prodotte da schiavi che da uomini amanti del proprio lavoro. La nostra ansia di svago e di libertà è la prova che la maggioranza di noi è impegnata in compiti cui solo un rappresentante di commercio avrebbe potuto chiamarci, non Dio di certo, o le nostre inclinazioni. Gli artigiani di stampo tradizionale che ho incontrato in Oriente sono inseparabili dal loro lavoro, e vi si dedicano fuori orario anche a costo di rimetterci.
Siamo arrivati al punto di separare il lavoro dalla cultura, e di ritenere quest’ultima come qualcosa da acquisire nelle ore libere; ma una cultura il cui mezzo di espressione non sia il lavoro non potrà che essere chiusa e astratta; se essa non traspare da tutto ciò che facciamo, vuol dire che ne siamo privi. Abbiamo smarrito il modo di vivere secondo vocazione, quello in cui Platone incarnò il suo modello di giustizia; e la prova più palese della gravità di tale perdita è il fatto di aver noi stessi procurato la distruzione delle culture di tutti i popoli che la nostra civiltà ha raggiunto con il suo influsso inaridente.
Per comprendere le opere che siamo invitati a guardare non servirà analizzarle secondo i canoni della nostra psicologia o delle nostre reazioni estetiche; se lo facessimo, commetteremmo un patetico errore. Non le comprenderemo se non accostandoci a esse con lo stesso atteggiamento dei loro autori. È compito dell’esperto istruirci sugli aspetti essenziali di quello che sembrerà a tutta prima uno strano linguaggio; infatti, benché i suoi termini non ci siano ignoti, oggi li usiamo con significati del tutto diversi da quelli originari. Concetti come arte, natura, ispirazione, forma, ornamento ed estetica dovranno essere spiegati al pubblico in modo chiaro. Nel pensiero tradizionale nessuno di quei termini era impiegato nel senso in cui lo usiamo oggi.

Dovremo anzitutto abbandonare l’uso del termine estetico. Infatti le arti non erano prodotte in vista del piacere sensibile. Il significato greco originale di questa parola è “sensazione” o “reazione” a uno stimolo esterno; la capacità sensibile implicata nell’aìsthesis è presente non solo nell’uomo ma anche nelle piante e negli animali, ed è definita dai biologi “reattività”. Si tratta dell’insieme degli impulsi che, identificati dallo psicologo come passioni ed emozioni, costituiscono le forze portanti dell’istinto. Platone ci esorta a resistere da uomini alle pulsioni del piacere e del dolore. Come è implicito nella parola “passione”, si tratta infatti di esperienze piacevoli e spiacevoli che noi subiamo, non sono atti compiuti da noi, ma stati che ci dominano; solo il giudizio e l’apprezzamento dell’arte sono “azione”. Costituisce esperienza estetica sia il tocco di una pelle che ci attrae, sia il gusto di un frutto che ci piace. “Contemplazione estetica disinteressata” è una contraddizione in termini e un controsenso. L’arte è una virtù intellettuale, non fisica; la bellezza si sposa alla conoscenza e alla bontà, di cui appunto costituisce l’aspetto attraente; poiché la nostra attrazione verso l’opera dipende dalla presenza o meno della bellezza in essa, la bellezza è dunque soltanto un mezzo indirizzato a un fine, e non il fine stesso dell’arte; lo scopo dell’arte è sempre una volontà di comunicare. Pertanto l’uomo d’azione non si accontenterà di sostituire la conoscenza di ciò che gli piace al giudizio di comprensione; né di trarre godimento da ciò che dovrebbe anche usare (per questo, a ragione, definiamo “esteti” coloro che si limitano a godere); nelle opere d’arte non lo interesseranno le superfici estetiche ma il giusto motivo o la logica della composizione. Ora, nelle opere esposte nei nostri musei la composizione non obbedisce a ragioni estetiche ma di espressione. Il giudizio decisivo non può che riguardare la capacità dell’artista di far emergere con chiarezza il tema del suo lavoro. È evidente che, per rispondere alla domanda “È stato detto bene?” dobbiamo sapere di cosa si doveva parlare. Ecco perché ogni dibattito sulle opere d’arte deve necessariamente iniziare dal loro tema di fondo.
In altre parole, dobbiamo considerare la forma dell’opera. Nella filosofia tradizionale “forma” non significa la figura tangibile ma è sinonimo di idea, se non addirittura di anima; l’anima, ad esempio, è definita la forma del corpo 〈1〉. Se si verifica quell’effettiva unità di forma e materia che ci si attende in un’opera d’arte, il suo aspetto concreto ne esprimerà la forma, che corrisponde al modello nella mente dell’artista, in base al quale egli realizza l’immagine materiale. Il grado del suo successo in questa operazione mimetica è la misura stessa della perfezione dell’opera. Così, si dice che Dio abbia chiamato buona la sua creazione in quanto conforme al modello intelligibile in base al quale operò; in modo del tutto analogo l’artista parla di “inverare” la sua opera. L’elemento formale dell’opera è la sua bellezza, la mancanza di forma ne determina la bruttezza. Se è priva di forma, sarà informe. Ogni cosa deve disporre di una buona forma.

Analogamente, l’arte non è alcunché di tangibile. Non possiamo definire “arte” un dipinto. Come implicano le parole “artefatto” e “artificiale”, la cosa realizzata è un’opera di arte, fatta con arte, non è arte in sé; l’arte rimane nell’artista come conoscenza grazie alla quale egli opera. Corretto è ciò che è fatto secondo l’arte, mentre ciò che si fa a proprio piacimento è probabile che risulti sgraziato. Non dobbiamo confondere il gusto con il giudizio o il piacevole con il bello, poiché, come nota Agostino, vi sono anche coloro a cui piace il deforme.
Le opere d’arte sono in genere ornamentali o variamente ornate. L’esperto potrà diffondersi sulla storia dell’ornamento, chiarendo che tutte le parole che significano ornamento o decorazione nelle quattro lingue di cui siamo più esperti, e probabilmente anche in tutte le altre, significavano in origine “corredo”; proprio come “arredamento” indicava in origine tavoli e sedie per l’uso corrente e non l’abbellimento di interni previsto per farci ben figurare coi vicini o apparire dei conoscitori. Non dobbiamo pensare all’ornamento come a qualcosa di aggiunto all’oggetto, in assenza del quale sarebbe stato brutto. La bellezza di una cosa spoglia non è accresciuta dall’ornamento, semmai solo posta in rilievo. L’ornamento è una caratterizzazione; gli ornamenti sono attributi. Non a torto si sente spesso dire che l’ornamento primitivo aveva un valore magico: infatti, attraverso la sua decorazione, una cosa veniva trasformata ritualmente e messa in grado di funzionare a livello sia spirituale che fisico. Ad esempio, l’uso dei simboli solari sui finimenti assimila i destrieri al sole; la sagoma circolare si addice ai bottoni perché il sole stesso è l’allacciatura primordiale con cui il filo dello Spirito tiene avvinte tutte le cose; la sagoma dell’embrione e del dardo era in origine quella che ancor oggi perdura in India, a forma di petalo di loto simboleggiante una base stabile. È solo quando vengono meno i valori simbolici dell’ornamento che la decorazione diventa una sofisticheria, avulsa dal contenuto dell’opera. Per Socrate, la distinzione tra il bello e l’uso è logica, non reale né oggettiva; una cosa può essere bella solo nel contesto al quale è destinata.
I critici odierni parlano dell’artista come ispirato dagli oggetti che lo circondano o perfino dal materiale impiegato. Ma è un uso errato del linguaggio, che preclude allo studioso la comprensione della letteratura e dell’arte antiche. Il significato univoco di “ispirazione” è l’influsso esercitato da una forza spirituale interiore; il dizionario Webster la definisce “influenza divina sovrannaturale”. Può darsi che l’esperto, se è un razionalista, preferisca negarne l’esistenza, ma non potrà esimersi dal notare che da Omero in poi il termine è stato sempre impiegato in un senso preciso, lo stesso inteso da Dante quando dice che Amore, ossia lo Spirito Santo, lo “spira”, “e a quel modo / ch’ei ditta dentro vo significando” 〈2〉.

Quando si afferma, ad esempio, che “l’arte imita la natura nel suo modo di operare”, con natura non ci si riferisce allo spazio visibile dell’ambiente in cui viviamo; né quando Platone dice “secondo natura” intende “il modo in cui le cose agiscono”, bensì quello in cui dovrebbero agire quando non “pecchino contro natura”. La natura tradizionale è la Natura Madre, il principio per il quale le cose sono “naturate”, per il quale, ad esempio, un cavallo è equino e un uomo è umano. L’arte è imitazione della natura delle cose, non della loro apparenza.
Su questa falsariga prepareremo il pubblico a comprendere il valore duraturo delle opere d’arte antiche. Se invece preferiamo ignorare l’evidenza e riteniamo che l’apprezzamento dell’arte debba solo consistere nella esperienza estetica, vuol dire che il criterio che seguiremo per progettare la nostra esposizione sarà quello di toccare la sensibilità del pubblico, cioè di avviarlo a reagire in chiave sensibile. L’idea che il pubblico sia un animale insensibile contrasta però stranamente con la testimonianza offerta dal genere d’arte che esso si sceglie da sé senza l’aiuto dei musei; il che ci dovrebbe far pensare che il pubblico sa già ciò che vuole: in particolare, i bei colori, i suoni gradevoli, tutto ciò che è vistoso, personale o aneddotico o che lusinga la sua fiducia nel progresso. Tale pubblico ama ricrearsi. Se dunque crediamo che l’apprezzamento dell’arte sia un’esperienza estetica, daremo al pubblico ciò che reclama.
Ma il compito del museo o dell’educatore non è quello di lusingare e divagare il pubblico. Se l’esposizione di opere d’arte o la lettura di opere letterarie vuole avere una sua funzione culturale, nutrendo e sviluppando quanto di meglio è in noi, come accade alle piante fatte crescere nei terreni più adatti, è alla comprensione che bisognerà appellarsi, non ai bei sentimenti. Per un verso il pubblico ha ragione, vuole sempre sapere “di che cosa” tratta l’opera. “Su che cosa il sofista” domanda Platone “è tanto eloquente?”. Diciamo, dunque, al pubblico di che cosa trattano queste opere, senza limitarci, come è nostra abitudine, a dire cose su di esse. Diciamogli la scomoda verità, ossia che la maggior parte di esse tratta di Dio, di quel Dio che ci guardiamo dal menzionare nella buona società. Abbiamo il coraggio di ammettere che se è nostro scopo proporre un’educazione che si accordi allo spirito e all’eloquenza delle opere esposte, non sarà un’educazione fondata sulla sensibilità, ma sulla filosofia nel significato attribuito a questa parola da Platone e da Aristotele, ossia su una ontologia e una teologia intese come guide di vita, nonché su una saggezza da applicarsi alle situazioni quotidiane. Riconosciamo che non si potrà raggiungere nulla fino a quando la vita e i valori saranno influenzati e modificati dalle pure apparenze. Assumendo questo punto di vista, non potremo che sopprimere la distinzione sociale ed economica tra belle arti e arti applicate; e senza consentire che l’antropologia sia scissa dall’arte, scopriremo che l’approccio antropologico all’arte si accosta a essa molto più strettamente di quello estetico; né ci sentiremo più di sostenere che i contenuti dell’arte popolare siano meno che metafisici. Insegneremo al nostro pubblico a esigere dalle opere d’arte soprattutto la chiarezza.

Procederemo, ad esempio, affiancando del vasellame dipinto del Neolitico, o una moneta forata indiana, a una rappresentazione medioevale dei Sette Doni dello Spirito, spiegando con l’aiuto di esperti o di didascalie, o di entrambi, che la ragion d’essere comune a oggetti così esteriormente diversi è la volontà di affermare la dottrina universale dei “Sette Raggi del Sole”. Accosteremo una rappresentazione egizia della Porta del Sole, che l’astro stesso custodisce, all’immagine del Pantokrator nell’oculo di una cupola bizantina, motivando che tali aditi spalancati sul cosmo corrispondono al foro attraverso il quale l’indiano americano entra o esce dal suo hogan, identico al foro nel centro del pi cinese, a quello della yurta degli sciamani siberiani, o infine all’apertura posta nel tetto al di sopra dell’ara di Giove Termino; e chiariremo che l’elemento comune a quelle costruzioni serviva a ricordare il dio Soglia, colui che poté dire “Io sono la porta”. Studiando la storia dell’architettura rileveremo che “armonia” fu anzitutto un termine utilizzato dai falegnami per indicare l’arte del “giuntare” e che, sia nella tradizione greca sia in quella indiana, fu inevitabile che il Padre e il Figlio fossero dei “falegnami”, dimostrando che tale teoria deve risalire al Neolitico, o addirittura allo stadio “iletico” o primordiale. Procederemo a una netta distinzione tra “educazione all’immagine”, capace di far cogliere solo l’aspetto esterno delle cose (e che ci spinge a reagire secondo l’impulso), e l’iconografia dell’invisibile (che invece ci guida al modo di agire).
Potrà allora accadere che la comprensione delle opere d’arte antiche e delle condizioni nelle quali vennero prodotte riesca a incrinare il credito da noi riservato all’arte contemporanea e ai metodi odierni di produzione. Sarà questa la prova del nostro successo come educatori; senza rifiutarci di constatare che ogni forma di educazione implica una rivalutazione. Tutto ciò che è fatto in vista del solo piacere, secondo Platone, è solo un giocattolo, progettato per il diletto di quella parte di noi che passivamente soggiace alle tempeste emotive; al contrario, un’educazione attinta alle opere d’arte sarebbe una guida ad amare ciò che è secondo l’ordine e a disdegnare quanto ne è privo. Abbiamo avanzato la proposta di educare il pubblico a porsi sull’opera d’arte anzitutto due domande: è vera? è bella? (con libertà di scegliere, fra í due termini, quello che si preferisce); a quale buon uso essa è diretta? Potremo così sperare di essere riusciti a dimostrare, esponendo le opere d’arte, che il valore umano di qualsiasi cosa prodotta sta nella coincidenza di bellezza e utilità, di significato e idoneità; che opere di tal sorta possono essere realizzate solo da uomini liberi e responsabili: liberi di considerare solo il bene dell’opera, e responsabili in prima persona della sua qualità; e infine che l’accostamento tra la manifattura artistica in atelier e la manifattura industriale priva di qualsiasi artisticità, rappresenta uno scadimento da un livello di vita umano a un livello subumano.
Quelle che ho esposto non sono opinioni personali, ma le logiche deduzioni di una vita intera spesa a maneggiare opere d’arte, a osservare uomini all’opera e a penetrare quella universale filosofia dell’arte di cui la nostra “estetica” non è che una fugace e provinciale aberrazione. Chi opera seriamente nei musei non ha che da concordare con Platone nel dire che “non si può definire arte ciò che è irrazionale”.
〈1〉 In modo analogo, l'affermazione (che cito dal Journal 0f Aesthetics, I, p. 29): "Sembra in questo caso che Walter Pater abbia ragione quando afferma che è l'elemento sensuale nell'arte ad essere essenzialmente artistico, dal che egli deduce che la musica è l'arte formale per eccellenza, e dunque la misura di tutte le altre", presenta una sorprendente contraddizione che può solo confondere l'infelice lettore. 〈2〉 Purgatorio, XXIV, 53-54. In alto: Ananda Kentish Coomaraswamy in una foto di anonimo del 1920 circa (courtesy Edward Wilkinson/www.asianart.com). Sotto: Ananda Kentish Coomaraswamy, Nudo reclinato, inchiostro su carta, inizi secolo XX, cm. 21.4 x 30.5, Cleveland, Cleveland Art Museum.



